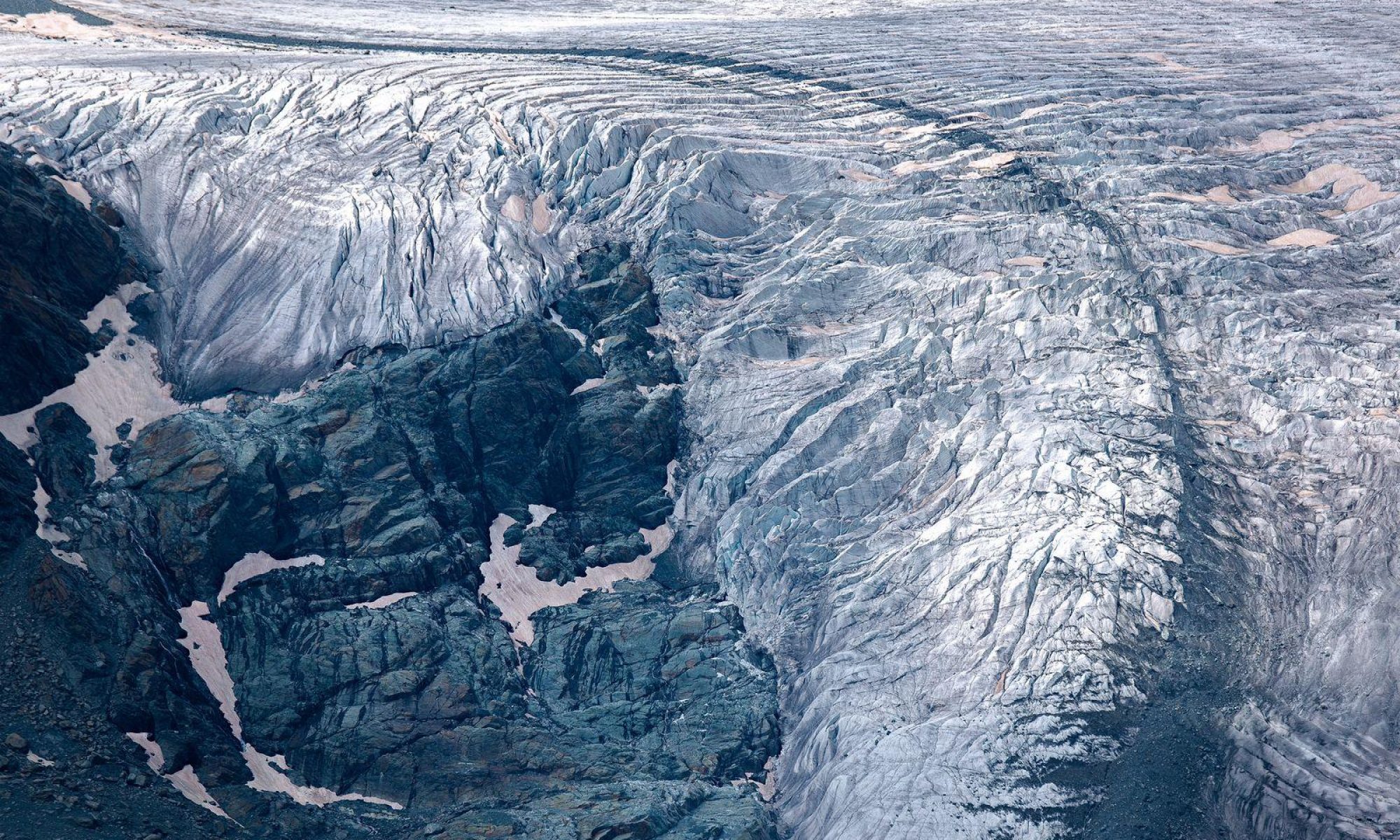[Riprendiamo questo articolo di Federica Graziani, pubblicato originariamente sul numero 60 della rivista “Gli asini”]

Alla vigilia di Natale, davanti al cimitero di San Bernardo, a Lodi, due uomini litigano. Il bisticcio prosegue senza soluzione, si articola e si esaspera finché uno dei due finisce per chiamare il 112. Una pattuglia di polizia locale arriva sul posto e, tentando di venire a capo delle rimostranze reciproche, le compone spiccando una multa e un ordine di allontanamento dal luogo in cui si è svolto il fatto verso entrambi i contendenti.
Questa piccola parabola di Natale potrebbe avere per titolo “Tra i due litiganti la Questura gode” e sembrerebbe suggerire che i provvedimenti con cui la polizia urbana appiana i diverbi nel comune di Lodi – trecento euro di contravvenzione e due giorni di espulsione dalla zona in cui la condotta illecita è stata accertata – siano disposti da un giudice un po’ troppo salomonico e particolarmente affezionato alla conservazione della pace cittadina, costi quel che costi. Ma come è possibile che un semplice bisticcio sia sanzionato così pesantemente? Per capirlo, bisogna andare alle ragioni per cui quei due uomini di nazionalità nigeriana la mattina del 24 dicembre si trovavano davanti al cimitero: erano lì per chiedere l’elemosina a chi, in occasione delle festività, andava a trovare le tombe dei propri cari. Il litigio è nato per stabilire chi tra i due dovesse fermarsi a mendicare qualche soldo in una giornata e in un luogo che la tradizione millenaria dei culti religiosi lega all’elargizione di offerte e alle opere di carità. E non riuscendo a venire a capo di chi fra loro avesse maggior diritto nella sventura, uno dei due si rivolge a un diritto superiore, quello garantito dei tutori dell’ordine cittadino. Ma quella invocazione incontra il nuovo regolamento comunale, approvato dalla giunta di Lodi nel febbraio del 2018, che “nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare” vieta di “infastidire in modo assillante i conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e/o servizi”. Con le conseguenze, in caso di trasgressione, che i due questuanti – evidentemente all’oscuro di quel che sui giornali locali è passato come “regolamento anti-accattoni” – hanno saggiato: una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e l’ordine di allontanamento, quel che sulla stampa nazionale compare spesso sotto la dicitura di Daspo urbano.
Voce complessiva che battezza due diverse misure di castigo per condotte ritenute illecite, l’ordine di allontanamento e il divieto d’accesso, il Daspo deve il suo nome alla parentela con il Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.a.spo., appunto). Quest’ultimo strumento, nato in seguito alla strage di Heysel – la tragedia avvenuta allo stadio di Bruxelles il 29 maggio 1985, poco prima dell’inizio della finale della Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, dove in seguito ai disordini dei tifosi vi fu il crollo di un muro e di una scalinata che provocò 39 morti e oltre 600 feriti – fu sancito prima nella legislazione europea, per essere poi accolto in Italia nel 1989 e avere una lunga vita di perfezionamenti normativi fino alla legge Amato del 2007. La normativa sul Daspo vieta non solo l’accesso agli impianti dove si svolgono le manifestazioni sportive, ma anche a quei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano e assistono alle partite di calcio. Il Daspo consente al questore di comminare un periodo di proibizione ad assistere alle partite di calcio per un periodo variabile (da uno a cinque anni), con l’obbligo di firma in Questura durante lo svolgimento della partita. Attorno alla sua applicazione, come nel caso di altri dispositivi preposti al controllo negli stadi – basti pensare alla Tessera del tifoso – si sono sviluppate consistenti e fondate polemiche di natura garantista. E così attorno alle misure di Daspo urbano, previste dalle nuove norme di polizia urbana della città di Lodi e da tanti altri regolamenti dei diversi comuni italiani che hanno recepito le disposizioni di legge “a salvaguardia della sicurezza urbana e del decoro dell’ambiente urbano”. La storia delle attuali politiche di sicurezza, con il loro portato di diffusione e sviluppo di un lessico e di un’ottica di approccio organico e continuativo rispetto al tema, in Italia nasce in una data precisa. È il 1992, e a Bologna si raduna un gruppo di amministratori, giornalisti, ricercatori, operatori sociali che fonda una rivista, “Sicurezza e territorio”. Quella prima iniziativa, ancora solo editoriale, si proponeva il fine di “divulgare in Italia la più matura esperienza dell’Europa del nord e di contribuire ad attrezzare il personale politico-amministrativo dell’Emilia-Romagna al diffondersi anche nelle città italiane di una nuova, impellente, domanda sociale di sicurezza”. Trascorrono due anni e, nel 1994, la Regione Emilia Romagna decide di raccogliere gli stimoli culturali e politici di quella redazione avviando il progetto “Città Sicure”, esperienza pionieristica che vede convergere a Bologna i maitrés a penser nazionali della criminologia sociale. E che lega il tema della sicurezza a un pacchetto articolato di strumenti politici integrati, animati da tre principi fondanti: il valore del governo locale nelle politiche criminali e preventive, l’importanza di accogliere con serietà le paure della cittadinanza nei diversi contesti in cui si manifestano e la necessità di sostenere e includere i soggetti vulnerabili, più esposti al rischio di criminalità.
Negli anni successivi, dal 1995 al 2001, le iniziative di miglioramento della sicurezza si moltiplicano in diverse città italiane, soprattutto nei capoluoghi provinciali e regionali al nord e al centro della penisola, amministrati da coalizioni di centro-sinistra. A seguito, da un lato, della sempre più intensa domanda sociale di sicurezza e dell’importanza che il tema andava assumendo nelle campagne elettorali locali e, dall’altro, della legge 81 del 1993, che introduceva l’elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province da parte dei cittadini. Il livello di coinvolgimento delle amministrazioni locali nel governo della sicurezza urbana e il rapporto, nell’ambito delle politiche cittadine, tra diversi interventi di prevenzione e attività di controllo e sanzione si comporrà variamente, dando origine a esperienze diversificate e frastagliate. Ma il Governo italiano fatica ad accogliere le esigenze delle amministrazioni cittadine e i tentativi di sperimentare nuove forme di collaborazione tra i due soggetti rimangono spesso tali. La competizione tra autorità dello stato e autorità locali per la ridefinizione dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno nell’amministrazione della sicurezza urbana prosegue con alterne vicende fino al 2008, quando la normativa in materia cambia radicalmente, dando ai sindaci poteri nuovi in qualità di “ufficiali di Governo”. Il 5 agosto di quell’anno l’allora ministro dell’Interno, Roberto Maroni, approva il decreto “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione” e qui, per la prima volta, viene integrata nella legislazione nazionale la nozione di sicurezza urbana come “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”. La sicurezza, così lascamente definita, trova una delineazione più puntuale nella specificazione degli ambiti di intervento previsti per i sindaci. I primi cittadini sono chiamati a prevenire e contrastare cinque possibili scenari urbani: “a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool; b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; c) l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b); d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico; e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso a essi”.
La sicurezza urbana incontra il decoro e la loro sintesi di “beni giuridici onnivori” (così Carlo Ruga Riva), più che chiaramente afferrabili, aumenta a tal punto la confusione e la vaghezza degli interessi protetti da lasciare di fatto ai sindaci stessi la decisione sulle condotte da sanzionare. Se il testo di legge non spende che poche parole (e poco chiare) sui comportamenti indirettamente considerati propizi al crimine, molti sindaci risolvono l’impasse contenutistica emanando una sfilza di ordinanze che prendono di mira in primo luogo il consumo e la somministrazione di bevande alcoliche e le attività connesse alla prostituzione in aree pubbliche (si sanzionano l’intralcio alla circolazione del traffico cittadino o gli abbigliamenti che manifestano intenzioni di adescamento, non la contrattazione delle prestazioni sessuali a pagamento, che attualmente non costituisce fattispecie penale nel nostro ordinamento). Seguono poi i provvedimenti volti a contrastare i fenomeni di vandalismo e danneggiamento di patrimonio pubblico (come i graffiti), l’accattonaggio molesto, gli schiamazzi, l’abusivismo commerciale, il bivacco, i lavavetri, il consumo e lo spaccio di stupefacenti e i parcheggiatori abusivi. Un margine di manovra dai contorni sterminati, che indurrà più di un commentatore a definire le ordinanze sindacali come “fantasia giuridica al potere” e condurrà la Corte Costituzionale a sostenerne “l’incompatibilità con il quadro costituzionale che tutela la libertà individuale da limitazioni e abusi”. Le nuove competenze e gli ampissimi margini di intervento assicurati agli enti locali dal decreto Maroni spostano sempre di più il tema della sicurezza urbana al centro del dibattito pubblico. Ma quale accezione di sicurezza si inserisce nell’agenda politica italiana degli ultimi anni?
La prima associazione recepita ed enfatizzata – da larghissima parte dei mass media, dalla classe politica e dall’opinione pubblica – è quella tra sicurezza e criminalità, che fa della prima uno stato individuale e collettivo da tutelare dai rischi derivanti dalla seconda, intesa come devianza, fucina inesauribile di rischi e insidie. I luoghi che abitiamo, in particolare gli spazi urbani, sono insicuri: vi si compiono reati che minacciano l’incolumità dei beni e degli affetti e a compierli sono soggetti che appartengono quasi sempre a determinate categorie sociali che, quindi, costituiscono in sé un pericolo per la nostra sicurezza. La sicurezza, insomma, diventa urbana e si esprime in relazione alla manifestazione, e alle strategie di controllo, dei fenomeni criminali.
Eppure la quantità e la gravità di questi ultimi, nonostante le difficoltà nell’interpretazione dei dati che riguardano i tassi di criminalità1, registrano un continuo calo in Italia, dal Duemila a oggi. Come mai, allora, in assenza di un’emergenza reale, il discorso e le politiche pubbliche sulla sicurezza si sono legittimate legandosi all’allarme sociale intorno alla paura della criminalità? L’uso politico della paura della criminalità può essere piegato a sostenere diverse funzioni: di rappresentazione comune del problema della sicurezza, di coesione della collettività, di affermazione di nuovi poteri, di attribuzione di stigmi sociali a gruppi marginali. Le istituzioni parlano di sicurezza attraverso le strategie di intervento e gli indirizzi politici contenuti negli atti che emettono: per verificare come negli ultimi anni si sia privilegiato il lato della sicurezza percepita (e come il ricorso a essa abbia giustificato interventi sempre più duri in una pluralità di fenomeni urbani che non hanno nulla a che fare con la criminalità, e infatti sono sanzionati in quel recipiente viscerale e arbitrario che è il decoro) rivolgiamoci, come il questuante di Lodi, ancora alla legge.
Nel febbraio del 2017, il Governo Gentiloni produce un decreto normativo in grado di ridefinire ulteriormente il concetto di sicurezza urbana e di introdurre nuovi dispositivi per la sua tutela. Il nuovo testo, convertito in legge due mesi dopo, contiene un lessico e un’ispirazione che si pongono in perfetta continuità ideale con il decreto Maroni. All’articolo 4, si incontra la definizione di sicurezza urbana: “si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”. A nove anni dal decreto Maroni, la sicurezza è stabilmente un bene pubblico da tutelare, come ribadisce il Ministro dell’interno Marco Minniti nel corso della conferenza stampa che introduce i provvedimenti intrapresi in materia di immigrazione illegale e sicurezza urbana. Nella relazione governativa al decreto, viene riportato che “l’intervento nasce dalla sempre più avvertita esigenza di una riflessione sul concetto di sicurezza che soprattutto oggi caratterizza la condizione di complessità propria dei grandi centri urbani. La nuova società, ormai tendenzialmente multietnica, richiede infatti – unitamente ai necessari interventi di sostegno rivolti ai “nuovi consociati” – una serie di misure di rassicurazione della comunità civile globalmente intesa, finalizzate a rafforzare la percezione che le pubbliche istituzioni concorrono unitariamente alla gestione delle conseguenti problematiche, nel superiore interesse della coesione sociale”. La normativa mira quindi esplicitamente a rassicurare i cittadini sull’impegno che le varie articolazioni locali dello Stato assumono nel migliorare la loro percezione della sicurezza urbana. Nel contesto cittadino, dove i flussi migratori e la crescita della povertà provocano, secondo alcuni, un senso di insicurezza e di paura diffusa il Governo dispone nuove collaborazioni tra gli attori istituzionali perché la cittadinanza perbene dorma sonni tranquilli.
Innanzitutto, il sindaco diviene il responsabile e il gestore della disciplina posta a tutela del decoro di particolari luoghi della città. Come recita l’articolo 9 della legge Minniti, questi sono quelle “aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze”, con il che si intendono non soltanto i punti nevralgici della mobilità, ma anche le strutture secondarie e complementari, quali i vagoni dei convogli ferroviari, le carrozze della metropolitana o le pensiline di autobus e tram. Chiunque, dunque, “ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all’accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all’art. 10, l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto”. Le norme possono estendersi anche ad “aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico” – aree che dovranno essere individuate dai regolamenti di polizia urbana. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono poi destinati a interventi di recupero del degrado urbano nel comune di riferimento. Il sindaco diviene insomma l’autorità competente a irrogare provvedimenti amministrativi a chi impedisca la fruizione di alcuni spazi pubblici, vietando di fatto ad alcuni cittadini di sostare in alcuni luoghi con gravissimo pregiudizio della libertà di circolazione, tutelata a livello costituzionale.
Oggi la sicurezza è tornata in auge fra le priorità governative in modo così spiccato da essere inserita in un testo che, ora come allora, è un decreto-legge, urgente e necessario, quindi rientra nel novero di quei procedimenti legislativi non animati da una distesa e completa discussione parlamentare. Il 28 novembre del 2018 Matteo Salvini, attuale Ministro dell’interno – ma lo dice “da cittadino italiano”, annuncia che il nuovo decreto sicurezza che “porterà più tranquillità, ordine, regole e serenità nelle città italiane” è diventato legge. Per quel che riguarda le norme in materia di sicurezza urbana non ci si discosta dal percorso tracciato dai precedenti legislatori. I poteri di sindaci, prefetti e questori in materia di decoro urbano e tutela dell’ordine pubblico sono aumentati e così le aree nelle quali si potrà comminare il Daspo urbano, comprendendo ora “presidi sanitari”, “esercizi pubblici e locali di intrattenimento” e quelle “aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli”. Tutti luoghi accomunati da un’intensa frequentazione di pubblico e dalla elevata funzione sociale che svolgono. Tra sanzioni sempre più severe contro i parcheggiatori abusivi e nuove misure per la sicurezza nei pubblici esercizi, è prevista anche l’introduzione del reato di esercizio molesto dell’accattonaggio. È punito con l’arresto da 3 a 6 mesi e l’ammenda da 3mila a 6mila euro “chiunque eserciti l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà”, con conseguente sequestro dei proventi e delle cose servite o destinate a commettere l’illecito.
Di tutta la materia legislativa che si preoccupa di disciplinare la sicurezza e di tutelare il decoro urbano, importa evidenziare due aspetti. Il primo sono i soggetti colpiti dalle sanzioni. Chi sono quei cittadini che turbano, con il loro passaggio o con la loro sosta, le stazioni, le piazze, i centri storici delle città (il cui decoro e la cui sicurezza sono il bene da tutelare)? Senza fissa dimora, immigrati irregolari, tossicomani o alcolizzati, rom, persone affette da disagio psichico, ex detenuti, prostitute, ambulanti, parcheggiatori, giovani o meno giovani che “bivaccano”, mendicanti. Non solo quindi le disposizioni di legge aggravano i fenomeni dell’esclusione sociale “quasi che le persone in difficoltà non fossero anch’esse parte della comunità locale, ma soggetti da contenere anche fisicamente” (così l’appello di Antigone, Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale, contro il decreto Minniti). Ma è, d’altro canto, facile immaginare che poche delle persone contro cui si appunteranno le sanzioni pecuniarie in esame saranno in grado di pagare le multe imposte – il che comporta un notevole rischio che incorrano in imputazioni penali (come l’inosservanza di ordine dell’autorità) – e che molte di loro al divieto di allontanamento risponderanno semplicemente spostandosi in quelle zone periferiche della città che inevitabilmente diventeranno sempre meno governabili e sempre più soggette a conflitti sociali.
Il secondo aspetto riguarda lo spazio: il perimetro bulimico e insieme minuzioso di “sanzionabilità” dei cittadini che turbano il benessere della comunità si sovrappone al perimetro dicotomico delle città in cui la legge viene applicata. L’attenzione al decoro è infatti cresciuta di pari passo con il consolidamento dei processi di “gentrificazione” dei quartieri popolari che hanno subito diverse città d’Italia, e d’Europa. Processi volti a tutelare gli investimenti immobiliari e i flussi economici e turistici, piegando la destinazione d’uso degli spazi pubblici a esigenze di consenso e relegando la socialità e la coesione comunitaria all’interno degli spazi privati. La cosiddetta “ideologia del decoro” si sposa insomma con un un processo di privatizzazione dello spazio pubblico che intende imporre una regolamentazione disciplinare mirata a ridurre il senso di insicurezza delle comunità attraverso una influenza rovinosa sulle dinamiche di vittimizzazione.
Arriviamo al cuore del bene tutelato dalle leggi sulla sicurezza, il decoro. La definizione di decoro esprime “dignità che nell’aspetto, nei modi, nell’agire, è conveniente alla condizione sociale di una persona o di una categoria; si dice anche, per estens., d’altre cose, col significato più generico di dignità, sostenutezza, decenza e sim.”, e ancora “decorazione scenica, scenario”, fino a “ornamento, onore, lustro”. Il destino delle due radici che concorrono a determinare l’ambito concettuale del termine – la dignità e la correttezza, da un canto, e le qualità esteriori e ornamentali, dall’altro – sarà però ben diverso. Dopo una lunga tradizione che vede il decoro fra i principi cardine della retorica classica e delle teorie poetiche e teatrali, in cui designa l’opportunità di stile in un soggetto e ancora pare tenere insieme l’aspetto della correttezza sostanziale e quello della convenienza formale, il termine passa all’ambito sociale, e qui si lega alle nozioni di galateo e buone maniere, perdendo progressivamente ogni nesso con la sfera della dignità. I precetti del decoro pubblico tendono irresistibilmente a concentrarsi sui limiti del comportamento adeguato all’interno di una certa situazione, e il termine sopravvive in età moderna come segnale della conservazione di una certa decenza esterna. L’antico vincolo con la dignità come intimo e indimostrabile valore dell’uomo, come status che non dipende da alcuna scelta né azione, da nessuna qualità se non dal puro e semplice essere umani, è rotto. Il decoro citato nelle leggi a tutela della sicurezza è parola che ha perso ogni riferimento alla dignità quale cuore su cui si fonda l’intera costruzione dei diritti civili e della vita associata, valore fondante la Costituzione Italiana e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, due carte alla base dello sviluppo delle nostre società (e nelle quali il concetto di decoro non ricorre mai).
Nei diversi testi di legge sulla sicurezza la parola decoro è spesso accompagnata dall’aggettivo urbano. E il riferimento alla città è sempre più ricorrente anche nell’attuale contesto mediatico, quando si parla di decoro, il che attribuisce al termine un aspetto ulteriore. Come luogo comune della cultura architettonica e urbanistica occidentale, il decoro nasce con le parole di un Salmo: “Signore, ho amato il decoro della vostra casa, in cui voi fate la vostra dimora; e qui fate risplendere la vostra gloria”. Il versetto è recitato dai sacerdoti quando si lavano le mani all’altare. Il salmista e così il fedele non possono che amare Dio e la sua gloria. Gloria che abita nel tempio e che il tempio riflette, pur se mai adeguatamente. Il decoro dei luoghi nasce come capacità proiettiva, costitutivamente allusiva a valori altri. E infatti, nella tradizione, si presenta con una tale quantità di accezioni da risultare un contenitore aperto, capace di riflettere qualsiasi istanza – da quelle di fedeltà all’esperienza storica, nel senso della permanenza dei principi del mondo classico, a quelle moralistiche in cui rappresenta (letteralmente) i valori ideologici e sociali del contesto storico in cui si situa (come la dialettica tra centro e periferia nella città borghese, cui corrisponde spesso una discriminazione classista di residenza). Ed è proprio questa capacità di riflessione che consente al concetto di decoro urbano di modellarsi tanto in differenti canoni artistici e architettonici quanto nelle molteplici pratiche di manutenzione della città da parte dell’amministrazione locale. Il decoro urbano, a suon di disposizioni comunali e norme degli enti territoriali, si presta allora a essere l’elemento unificatore per disposizioni del tutto diverse: si incontreranno ordinanze che vanno dalla regolamentazione del traffico ai divieti di bivacco e di schiamazzi notturni, dall’interdizione al consumo di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti a quella di consumo di cibo all’ingresso dei monumenti cittadini, fino ai divieti di campeggio, di imbrattamento di muri con scritte e disegni realizzati a vernice, di bagni nelle vasche pubbliche, di ingresso e circolazione nei pubblici esercizi in costume da bagno o a torso nudo, di deiezioni in strada, di accattonaggio. Del concetto mutuato dall’urbanistica, allora, che esprimeva ancora un concetto estetico e morale, una qualità sociale della città che trovava il suo corrispondente nella responsabilità civile del cittadino nei confronti della collettività, che ambiva a istituire un parallelismo tra decoro e tensione etica e culturale della comunità urbana, rimangono l’involucro di una cosmesi tutta esteriore, una quantità di divieti che inducono a un rispetto dell’ambiente senza consapevolezza della sua complessità e una frattura – istituita per norma di legge – nell’armonica relazione tra la città e i suoi abitanti. E tra alcuni abitanti e alcuni altri, legame che al contrario costituisce il senso stesso di ogni progetto di città, di ogni legislazione e di ogni politica locale. Avvilire il gesto del chiedere, come è capitato ai due uomini di Lodi che si sono affidati a una giustizia che si è rivelata poco tale, monta l’indistinzione tra illegalità e disturbo, tra criminalità e disagio, tra reati e inciviltà fino a rendere la generosità miseria e la miseria delitto.